|
Le terme
Non
solo gli acquedotti contribuivano a mantenere l'igiene in Roma e la salute nel
popolo romano che era dedito, in ogni stagione, a far uso di bagni caldi o
freddi: le Terme.
La parola Terme letteralmente significava " bagni d'acqua calda per calore
naturale od artificiale". In seguito significò l'edificio che conteneva
uno stabilimento di bagni freddi e caldi sia d'acqua sia di vapore.
Prima dell'avvento delle terme, i Romani si accontentavano di bagnarsi entro
umili bacini, senza decorazioni e lo facevano in luoghi bassi che avevano più
che altro aspetto di grotte poco illuminate. Questo ai tempi di Catone, di Fabio
Massimo e dei due Africani; ma in seguito fu un susseguirsi di costruzioni
termali dove si potevano trovare varie comodità.
Si accedeva alle terme pagando una tassa al portiere se queste non erano
gratuite per volere di un donatore.
Tutt'oggi rimangono ruderi a testimonianza di quelle che furono le terme di Tito
sull'Esquilino, le terme di Diocleziano che occupavano una parte del Vicinale e
del Quirinale. Per immaginare la vastità di queste ultime terme, basti pensare
che una sua sola stanza fu convertita da Michelangelo nella chiesa di S. Maria
degli Angeli, seconda, per dimensioni, solo a quella di S. Pietro.
L'imperatore Agrippa lasciò, alla sua morte, le proprie terme ad uso del popolo
romano. Ci furono le terme di Nerone, di Settimio Severo, di Giordano:
quest'ultime avevano ben duecento colonne di marmo.
Le ultime terme costruite all'epoca romana furono quelle di Costantino.
Ho tralasciato nell'esposizione i ruderi che ricordano le terme di Caracalla.
Queste sono uno dei più grandiosi monumenti dell'antica Roma per quanto
riguarda l'uso delle acque termali.
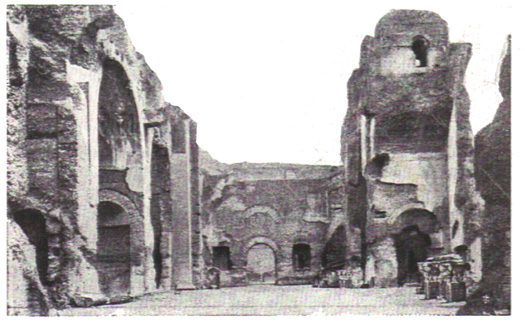
I
Greci avevano locali per il bagno annessi alle palestre,
non avrebbero mai potuto sognare
nulla di simile alle
terme romane.
Dovete pensare alle terme dei Romani come stabilimenti di bagni che, al tempo
stesso, fossero un luogo di ritrovo, di conversazione, di ginnastica con tutti
gli agi, le eleganze, le ricchezze della città imperiale.
Cerchiamo
ora di immaginare quelle che erano queste terme. Secondo una pianta fatta
dall'architetto Pardini abbiamo un'idea della loro sontuosità per la grandezza
delle sculture e degli ornamenti.
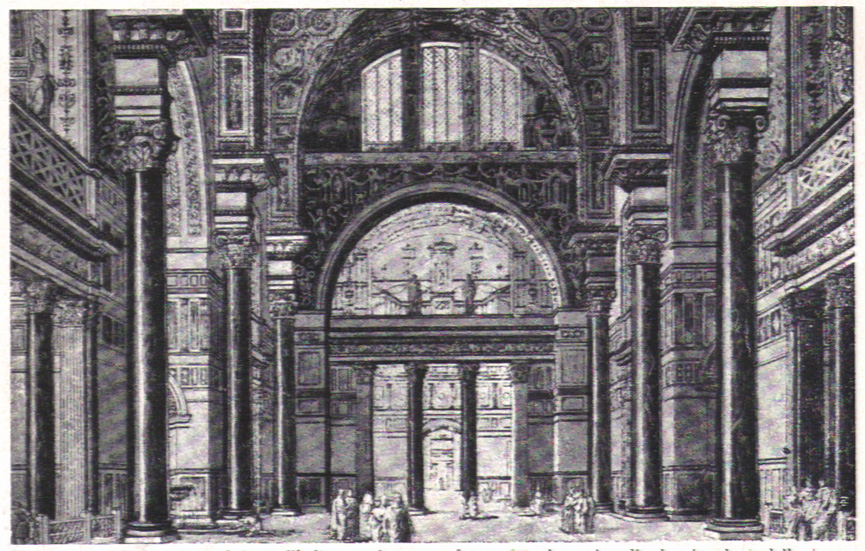
La
facciata veniva arricchita da un vasto portico a colonne. In questo portico si
susseguivano tante celle, in fila parallela alla colonnata, con annessa una
stanza adibita a spogliatoio (apodyterium) per le persone che non volevano
bagnarsi in comune.
Tre corridoi paralleli erano situati di fronte ai lati e dietro il corpo
centrale dell'edificio. In uno di questi c'erano due sale semicircolari dove si
ritrovavano letterati, filosofi e sapienti a convegno, distesi sopra sedie.
Dietro il corpo centrale dell'edificio e dietro ai corridoi, che anche da questa
parte lo cingevano, c'erano i passeggi scoperti (hypaetrae ambulationes) con
piantagioni e viali d'alberi ed arbusti, con spazi vuoti nel mezzo, per gli
esercizi ginnici: uno stadio con sedili di pietra e di marmo all'intorno. Dietro
lo stadio stavano, con altre stanze per usi diversi, i grandi serbatoi d'acqua (castella)
con sotto i fornelli che la riscaldavano sino ad un certo grado per poi
travasarla attraverso tanti tubi sotterranei nelle stanze adiacenti. Qui si
facevano bagni tiepidi (cella tepidaria). 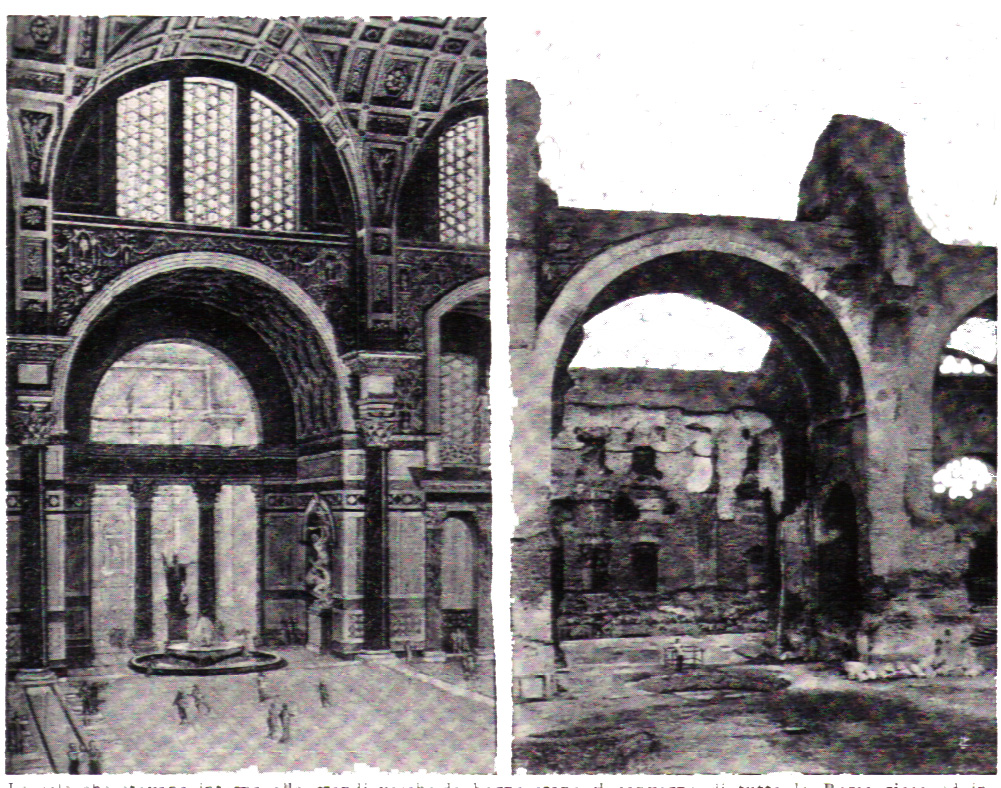
Tutto
questo era all'esterno del corpo centrale dell'edificio dov'erano disposte tante
altre stanze da bagno. Qui era scavato un vasto bacino (natatio) colmo d'acqua
fresca che si rinnovava sempre dove s'intrattenevano i nuotatori. Questo bacino
era fiancheggiato da tante celle che servivano per bagni freschi privati (cella
frigidaria), e da altre per uso spogliatoio (apodyteria) e per gli schiavi (capsarii)
che avevano in consegna le vesti dei bagnanti.
Il tetto che copriva tutta questa porzione del corpo centrale era sostenuto da
otto immense colonne.
Verso il centro c'era una grande caldaia o serbatoio d'acqua molto calda (calidarium)
con attorno stanze e tinozze (labra) per bagni (cella caldaia). Il tetto di
quest'altra sezione era ancora sostenuto da otto grandi colonne. A questo
scompartimento succedeva una grande stanza di forma circolare, destinata al
bagno a vapore (laconicum vel sudatorium).
Per permettere ai bagnanti di passeggiare nelle giornate piovose o fredde, dopo
il bagno caldo, erano praticate ai lati e presso i corridoi già citati due
grandi sale ben illuminate, coperte e ricche di sedili.
Ai lati dei bagni a vapore c'erano quelli freddi per immersione (baptisteria);
poi le stanze per ungersi (elaeothesia) e le camere fresche per rinfrescarsi (frigidaria).
Sopra il corpo centrale sorgeva un altro piano. Qui v'erano le gallerie di
quadri e le biblioteche per chi voleva ricrearsi lo spirito dopo aver curato il
corpo.
Tali erano le terme di Caracalla aventi una circonferenza di 1850 metri: alle
terme servivano molti schiavi e schiave, al servizio dei due sessi, oltre a
quelli che avevano in consegna le vesti, come detto sopra, appartenenti ai
bagnanti.
Questi schiavi erano distinti in: untori o profumatori (aliptae vel unctores),
confricatori o premitori (alipili et tractatores). Tutti questi, oltre a quelli
che stavano ai fornelli per scaldare le acque, erano diretti da un capo (fornicator)
e pronti a servire il pubblico.
I cittadini romani usciti dal bagno si adagiavano sopra dei letti entro stanze
ben calde ove un giovane premitore li massaggiava premendo il corpo e
rigirandolo in ogni parte; quando le membra diventavano molli le stirava
dolcemente e piegava le articolazioni facendole scricchiolare. In seguito dava
inizio a raschiature con un raschiatoio (strigile) o corno d'avorio o argento,
curvato in modo da adattarsi alle rotondità del corpo. Così staccava dalla
pelle dei bagnanti ogni deposito che vi fosse rimasto dal sudore o
traspirazione.
Dopo questa seconda operazione si passava ad una leggera unzione con pomata
composta di lardo, d'olio, di sostanze odorose poi ad una seconda, con oli ed
essenze profumate, per calmare e far scomparire il rossore che vi aveva prodotto
la raschiatura. Infine la pomata e l'olio erano tolti con panni di lino o lana
finissima; dopodiché la cura balneare aveva termine.
Naturalmente né in provincia né in case private si poteva avere così tanto
lusso quanto nella capitale, cui affluivano le ricchezze del vasto impero
romano. Gli antichi scrittori ci dicono che i bagni delle case private fossero
spesso piccole meraviglie di raffinatezza e lusso. Questi ci hanno tramandato
che anche nelle più remote province si cercasse di abbellire le pubbliche
terme: lo dimostrano le opere d'arte trovate in esse, infatti, la maggior parte
dei mosaici esistenti provengono dalle terme.
Gente appassionata ai bagni come i romani non poteva trascurare le sorgenti
termali, fossero esse in Transilvania o nei Pirenei, nella lontana Germania o
nella patria Italia. Quasi nessuna delle grandi città termali fu sconosciuta ai
Romani, ma nessuna fu più frequentata di Baia (presso l'attuale Pozzuoli). La
vicinanza di Roma, la bellezza della natura, la mitezza del clima nonché tutte
le lusinghe del lusso e dei divertimenti, n'avevano fatto il luogo d'incontro
favorito dal bel mondo romano, in confronto al quale scolorisce la fama di Vichy
o di Wiesbaden.
|